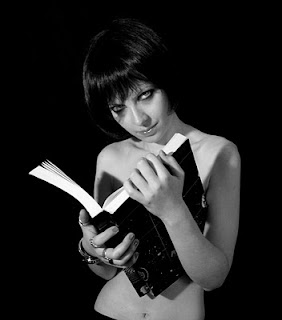Potevo desiderare di più per questo fine decennio?
mercoledì 29 dicembre 2010
lunedì 27 dicembre 2010
S. Crozzoletti su "C'è bufera dentro la madre"
C'è bufera dentro la madre (L'arcolaio 2010) di Stefano Guglielmin potrebbe diventare, per chi arriverà dopo di noi, testimonianza preziosa della decadenza di un mondo che pensava di essere meravigliosamente ricco ed eterno, immagine viva di parole, opere e omissioni di esseri umani impegnati a vivere una vita infinita bagnata dal denaro, dall'appagamento immediato dei propri desideri, dal benessere a tutti i costi.
La lettura di questo libro mi ha fatto pensare ad uno scenario possibile in futuro non troppo lontano, fatto di capannoni semidistrutti, fabbriche dismesse, zone industriali fantasma nell'area che fino a qualche anno fa si trastullava soddisfatta nello splendore del proprio “miracolo economico”, il nordest italiano. Un quadro desolante, specchio di un ben più grande abbandono, umano e sociale, rappresentato da Guglielmin con sguardo lucido e pennellate rigorose.
“C'è bufera dentro la madre” ci mette di fronte ad una sequenza di immagini che precedono una conclusione che, anche se non raccontata esplicitamente, sappiamo dolorosa. Assistiamo ad una anomala via cruscis che, stazione dopo stazione, mostra con una impietosa lente di ingrandimento “quel solido nulla dove la vita trottola e canticchia”, strada che conduce inesorabilmente alla fine. Una fine che è riavvolgimento, eterno ritorno, penoso loop senza pace né speranza.
Il percorso di cui ci parla Guglielmin, fatto di fotogrammi spietati, implacabili, è una crepa che si apre e che via via si estende nel corpo della madre, nel cuore dell'umanità, una ferita sempre più aperta che attrae e annienta le anime. E' così vera, questa rappresentazione, da lasciare ammutoliti. Verrebbe da coprirsi gli occhi con le mani, come quando si assiste ad una scena violenta di un film. Ma, piano piano, lo spazio tra le dita si allarga, lascia intravedere la verità senza fiocchi, nuda, pura e per questo devastante. Perché non è così lontano da noi il protagonista della “Bufera”. La sua famiglia, la sua impresa, le sue vacanze sono pericolosamente vicine. Non ci vuole molto a far combaciare facce, corpi, pensieri, “la spocchia / di chi ha i numeri migliori”.
Sono rari, e terribili, i momenti della consapevolezza. Quando l'idea della morte si avvicina (“una bocca / impagabile, una ciste che va in fregola appena la sfiora”), quando il nostro uomo in segreto invidia il senso di comunità e di vicinanza degli operai che vivono “grattando becchime”, quando egli “prega abele di non lasciarlo solo”. Quando avverte “qualcosa” che lo inquieta. E' come se si trovasse nell'occhio del ciclone, centro della devastazione dove regna irreale la calma, o al massimo tira un po' di vento, mentre a breve distanza tutto viene travolto. E' solo questione di tempo, il nostro uomo sembra in qualche modo percepire il cambiamento, lo annusa, tuttavia preferisce ignorarlo, allontanando il fischio della propria coscienza. Nemmeno l'ultima invocazione viene ascoltata:
se dalla luna, lui, portasse indietro un grammo di ragione
o il suo lume. se studiasse i modi finiti e infiniti di spinoza
e vi scavasse dentro una pozza di vita vera. se insabbiasse
il perno che lo lega alla pancia del denaro. se ogni tanto
si girasse come l'angelo di klee. se inorridisse.
Nessun riscatto, nessun cambio di direzione, ma un ripetersi colpevole delle medesime mancanze. Il nostro uomo s'è perso, e noi con lui.
Stefania Crozzoletti è nata nel 1966 a Isola della Scala (Verona), dove vive. Laureata in Economia e Commercio, si occupa di studi e ricerche economiche. Sue poesie sono state pubblicate nelle antologie della Giulio Perrone Editore Pensieri d'Inchiostro III edizione e La notte. I grandi temi della poesia. La sua raccolta (Non sono un) poeta è stata segnalata nel concorso di Fara Editore Pubblica con noi 2008. Sempre con Fara, Prima vita (2009, opera prima)
venerdì 24 dicembre 2010
Concorso di Natale
Voi postate nei commenti la vostra poesia di Natale ed io, in principio del prossimo anno, ne scelgo una e la commento
lunedì 20 dicembre 2010
Furia su Ermanno Bencivenga
Filosofici giochi
Con "Parole in gioco", Ermanno Bencivenga presenta una raccolta di brevi prose partecipi sia dei caratteri propri della narrazione assurda ed umoristica, sia di quelli della riflessione filosofica: il sottotitolo "Il linguaggio stralunato della filosofia", pertanto, appare del tutto appropriato.
Le parole sono considerate oggetti con i quali, davvero, si può giocare.
"Volevo andare in un'isola, ma non mi è stato possibile" ... "La meta che avevo scelto era Malta, e non si può, assolutamente, andare in Malta, quindi non si può andare nell'isola in cui avevo scelto di andare. Lo vieta la grammatica".
Il linguaggio è dunque limite insuperabile, prigione da cui è impossibile evadere?
Il linguaggio è dunque limite insuperabile, prigione da cui è impossibile evadere?
Non pare: per l'autore la grammatica è possibilità, umana forma di rappresentazione del mondo sempre modificabile.
Chissà quanti inediti accostamenti potrebbero affiorare se soltanto riflettessimo di più e meglio sulla lingua adoperata, chissà quanti nuovi nessi si nascondono dietro ai lineamenti idiomatici cui siamo abituati.
Vediamo.
"Il mio orologio va indietro" ... "Il mio orologio cammina diritto, senza sbandare, ma invece di andare avanti va indietro".
Insomma, è un orologio che si rivolge al passato: un orologio che è tale e, nel contempo, non lo è.
O, meglio, non lo è ancora: lo diventa nel momento in cui qualcuno ne parla.
Occorre non restare prigionieri dei comuni canoni.
"Non è intellettualismo: non ci s'intabarra in gerghi intollerabili, in dispute intestine; non s'intorbidiscono le acque; non s'intossica la comunicazione. S'interviene invece a sancire un'intesa con il proprio essere, a stabilire interlocutori per un dialogo e intermediari per uno scambio; s'intavola un'interrogazione interminabile, un intrattenimento infinito dello spirito".
Si tratta di non abbandonarsi al conformismo, d'imparare di nuovo a giocare.
Nessun cedimento nei confronti di scelte di tipo solipsistico accompagna quest'intento: mostrare il gioco (per esempio, scrivendone) è coinvolgere in un'attività contagiosa.
Quanto alla filosofia, beh, ci siamo già.
Lungi dal proporre complicate teorie o astratte speculazioni, Bencivenga pone il suo scritto nell'àmbito filosofico per via di gesti linguistici concreti.
L'assurdo non preoccupa, anzi diverte: si può davvero giocare con gli schemi, riuscendo così a dischiudere, con raffinata leggerezza, i vasti territori della possibilità.
Ecco l'insegnamento: quanto appare non consono, diverso, perfino strampalato, può risultare tutt'altro che irrilevante.
Un geniale fisico, all'inizio del secolo scorso, forse non modificò in maniera sostanziale (e proficua) il concetto di tempo, scardinando modelli ritenuti fino a quel momento indiscutibili e dati a priori?
L'esercizio che "Parole in gioco" propone è di non poco valore: non tutti riusciranno a raggiungere certe vette, ma, senza dubbio, ognuno potrà assumere atteggiamenti meno rigidi nei confronti della propria vita e del mondo.
Come?
Imparando a giocare.
Marco Furia
(Ermanno Bencivenga, "Parole in gioco", Oscar Mondadori, 2010, pp. 84, euro 9)
Ermanno Bencivenga (Reggio Calabria, 1950), professore ordinario di filosofia all'Università di California, è autore di numerosi saggi di logica, filosofia del linguaggio e storia della filosofia.
Dirige la rivista internazionale "Topoi" e collabora a "La Stampa".
Tra i suoi ultimi titoli: La filosofia in quarantadue favole (2007) Il pensiero come stile (2008), La filosofia come strumento di liberazione (2010).
È autore delle raccolte di poesie Panni sporchi (2000), Un amore da quattro soldi (2006), Polvere e pioggia (2010).
giovedì 16 dicembre 2010
Luisa Pianzola
Luisa Pianzola, con Salva la notte (La Vita Felice 2010, nota critica di G. Fantato e postfazione di M. Santagostini) conferma di essere una delle migliori poetesse della mia generazione. Con questo libro, poi, porta a compimento il suo viaggio verso il termine della finzione, per darci il mondo nel suo crudo malessere, nel suo quasizero che è diventato. Non solo: l'umana compulsione a costruire e distruggere, narrata nella sezione (il tempo delle cose), non viene semplicemente osservata nel suo stucchevole non-senso, bensì interrogata, quasi nella convinzione che la stessa idea critica sul mondo in sfacelo sia un pregiudizio, un effetto dell'umano orizzonte, visto da chi ha perso. L'ideale sarebbe diventare invisibili al desiderio, essere come l'ultima cosa del mondo, così da vivere la libertà della presenza senza contagi di sorta. Come la vecchia che si vorrebbe "liquame [...] per vedere cosa c'è dietro tutto questo". "Questo", direi, è la griglia che tiene in tensione dialogica la res cogitans e la res extensa, è il reticolo dentro il quale ogni evento accade e che noi riconosciamo come "il vero". Intrecciato a questo motivo ontologico, troviamo il filo esistenziale, la vita agra che insegna a non tentare voli azzardati, per ambientarsi, invece, "al buio / o al massimo a un breve chiarore". Altro non possiamo, ci dice Pianzola, per sopravvivere alla crudeltà della natura, che ci fa a "pezzetti", e a quella della cultura, che ci soverchia "la gioia". Il richiamo, mi pare, è al Leopardi del pessimismo cosmico, anche se nel titolo traspare invece il poeta ancora illuso che un tempo buono sia forse esistito nell'antichità e forse ancora sopravviva negli ingenui: "Dolce e chiara è la notte e senza vento", il memorabile verso incipitario de La sera del dì di festa, mi pare infatti sopravviva, sia pure mutilato, in "Salva la notte", se non altro grazie al riscatto che l'amore potrebbe offrire, se vissuto pienamente. Purtroppo, tuttavia, anch'esso, qui, si dà lacerato, corrotto da una bufera dal piglio dantesco: "Dio dei terremotati e dei dispersi, che cosa si è abbattuto su di noi?" chiede implorante una voce in cerca d'amore in principio della sezione dedicata agli affetti, dall'emblematico titolo (tempesta, tempesta forte, tempesta dura). Questi canti del disamore, tuttavia, lasciano intendere che abiti qui la via d'uscita dal non-senso storico, non tanto nell'agire dei corpi e delle parole, ma nei loro silenzi, nelle loro pause, nelle quiete attese che fanno fiorire la speranza di un tempo non operoso, di una foscoliana "sera", anzi di una notte che salvi dallo struggimento diurno. "Qualcosa tace e ci conforta" recita infatti una delle ultime poesie del libro, aprendo all'infanzia quale altrove salvifico, purché legato alla consapevolezza d'essere mortali. Sta in questo confine, in questo stare "tra due fuochi", tra la vita e la morte, il farmaco capace di sollevarci dal dolore e dalla solitudine che la misura razionale della realtà comporta. Lo dice bene la poesia di epilogo: "Prima di andare, Lorella, siedi un po' qui con me. / Prima di vederci chiaro, per un attimo, spoglia lo sguardo / della prospettiva, stai tra due fuochi. / Che non s'incendi la vista, però. Che c'inneschi una nascita / anche minima, da morituri."
Un colpo d'ascia, di netto, abbatte il frassino adulto.
Del resto non credevamo in lui, come non crediamo
in chi non resiste.
Resistere all'ascia, da piccoli si fa, si riesce. Ma l'adulto
vacilla, scricchiola, cede, vede doppio.
II
Dice voglio diventare vecchissima, voglio essere vecchissima
decrepita senza più desideri, oltre la tensione visibile,
un liquame adagiato su vicende private, un dirupo vergognoso
che mi crolla ancora addosso. Dice voglio arrivare a essere
vecchissima, senza più giovani intorno, ornata solo di sabbie
armate immobili per vedere cosa c'è dietro tutto questo,
cosa c'era dietro tutto questo. Incappucciata in una storia risibile,
ormai non più vista né osservata, vedere come intruglio
maleodorante il vero motivo di tutto questo il vero (...)
**
II bene salva. Abbiamo attraversato il tunnel di stazioni
irriconoscibili per velocità di passaggio e fermate non richieste.
Poi il buio delittuoso di una contrattazione rapida, marciare
veloci, qualcuno che imprecava. A quel punto la paura
aveva già consegnato la ragazza (chiamiamola così) alla schiera
innocua di quelli che vanno. Voglio dire: si stava allontanando,
le sembianze non erano più le stesse, la si portava via da noi.
Senza allarme, senza orrore. Con una certa cordiale meticolosità.
Ma il buio, a volte, salva. Salva la notte.
Di mattina gli arti spossati, pesanti quintali. La fatica di essere
di nuovo leggeri.
**
Ottobre carsico, ma anche gentile. Tra l'inizio e la fine,
in una staticità accudita, tutto parla di un sentimento mediano,
gregario malpagato e riconoscente. Riconoscenza, ecco come
respingere le ondate estive irrisolte. Senza guardarsi indietro,
attraversando muri a spallate.
**
Quanto vuoi bene alle molecole che accarezzi prima di cadere.
Il sangue ti avvicina, tu lo insegui e baci, senza esser visto,
le sue labbra: tutta meraviglia. Quanto vuoi bene, quanto ami
senza esser visto, senza imparare. Di' un nome: è anche quello
il tuo mestiere. La pena di dire «anch'io rischio di perdere,
anch'io ho già perso».
**
Ma nessuna fonte rimane per sempre là
dove si trova, né il corso delle sue acque è eterno
II tempo delle cose è brevissimo, eppure operai demoliscono
insistentemente per costruire una multisala. Scavatrici
in funzione, materiali edili in quantità indescrivibile: io per me
infilo in fretta le scarpe alla mattina per scampare al crollo
prevedibile e correre da qualche parte. L'inguine nei pantaloni
non parla, ammutolito stancabile sfinito. E un tempo incolume
finora, mi dico, ma a fatica lo intendo, a fatica assumo
posizioni durevoli. Non è certa la causa, l'effetto addirittura
manca, ma quotidianamente insisto in un tempo che resiste,
dentro una storia non richiesta che non rischia suoli,
non escogita.
**
Da un po' mi attraggono le sante, quelle che si ammalavano
gravemente e prendevano il dolore come un premio speciale
del padreterno, il segno che gli voleva proprio bene.
Teresina, per esempio, diceva che Gesù era un ladro
e la voleva rubare. Lo diceva con un sorrisetto furbo mentre
la fatica di respirare la faceva sobbalzare sopra il letto.
Ha parlato così un'estate intera, con boccioli di gardenia
che le uscivano dal petto.
**
Ci pensi, essere una pecora. Meraviglioso il prato, meraviglioso
il recinto, inutile sconfinare.
E l'orizzonte, come lo vedresti?
Come l'orlo del mastello dove mi piacerebbe bere. Né più
né meno che un punto lattiginoso del creato dove la provvidenza
mi ha depositato.
Qui altro su di lei e sulla sua opera.
domenica 12 dicembre 2010
3 inediti miei
sabato 11 dicembre 2010
Annino: un inedito
Le due facce della medaglia
All’aperto abbiamo
le stesse idee, l’arte, però! Avvocato
dei miei desideri su fondo
oro, l’annunciazione
di lei, ampia legale, si discuterà
con parole nuove. Noi signori del Foro.
In tanto realismo che pare
scalza la stanza, dopo l’ingresso
davanti
a Hopper, così senza polpa: sembra
vero! dice, poi: triste! E ride, lo
fa, con quella voce forte nella
calma. Forse pensa, non
so. Ma che c’entra, t’aspettavi
una croce? poi esco correndo
sull’acqua calda, di pala in
pala adorando! Io gotico, lei
ridente. La porterò da Wyeth, se
ci riesco.
( Ma che pensi davanti
al realismo, me l’invento
come l’amassi; ha tanto più
d’estremo, quel
pensiero. Mi mette alla prova
più d’un vizio
segreto o l’odore troppo fresco
d’ intonaco. Mi rimescola, il tatto
sopra, così tra passato remoto
e presente, com’il cameriere
che in un lampo si riprende
il piatto. Non c’è
rottura di pesi, il linguaggio
tiene. Per questo dovremmo
godercela – esclamo al centro del
Foro- la faccia ridente
dell’Ultima Cena, che nella
sinopia con gusto, si mangia pure
la natura morta con lavanda
dei piedi. Ecco! io che
vivo nel trecento asciutto, ma
anche vedo il tormento di Hopper)
qui un omaggio di Nadia Agustoni.
lunedì 6 dicembre 2010
Amelia Rosselli
Cara Romina,
a proposito della lettura di Documento (Garzanti, 1976) di Amelia Rosselli, fatta assieme nel Laboratorio Artemis: tu dici che "qualcosa non torna" leggendo i suoi versi. Per capire che cosa sia, credo convenga partire da due fulcri, due costanti che agiscono in contemporanea sulla sua scrittura, che sono, direi, la geologia e la genealogia. Quello che spiazza, anzitutto, per un orecchio come il tuo, esperto di metrica e retorica, è l'incostanza, perfino l'incoesione dei materiali di cui è fatta ciascuna sua poesia, frutto dell'emergere di differenti stratificazioni psichiche e sensoriali: l'autrice passa infatti – senza soluzione di continuità se non quella, ma non sempre, versale – dal magma fluido dell'inconscio (causa delle metafore surrealiste), alle cristallizzazioni, profonde ma ormai sedimentate e urticanti, con le quali esse stessa confliggeva, evidenti nelle asperità del carattere (misto di educazione e selva, tradotte in figure ossimoriche, quali "libidine di saggezza" e "continuità a singhiozzo" della poesia perdona le colpe), sino alle espressioni domestiche, di superficie, in una sorta di rapimento anestetizzante prodotto dall'adesione ingenua al presente, rapimento che tuttavia conserva ancora uno strascico tragico (tipo: "entrare nella cucina e non vedere più la propria moglie") e alla logica, infine, che si fa giudizio sul mondo: "Vinse il migliore nel peggiore dei modi"). Dunque, magma, cristallizzazione, registro informale, scelta gnomica costituiscono una geologia predatoria, che la stessa Rosselli vive con ansia, ma anche nella speranza che, diventando scrittura, possa "vaccinarla", ossia garantirle sopravvivenza dentro un mondo malato. A tutto ciò si mescola l'elemento genealogico-biografico: pensa alla sua esistenza nomadica, emblema di una modernità senza patria, di uno spaesamento che colpì i grandi scrittori del Novecento, i quali, proprio nella ricerca di un centro, edificarono la loro opera (penso a Canetti e a Camus, per esempio); ma più forte ancora fu la morte del padre, che si presenta come fantasma amoroso in tantissime sue poesie, un fantasma amletico capace di inoculare in lei un senso di colpa insopportabile, e forse persino quella paranoia persecutoria che le fu diagnosticata già negli anni Sessanta e che lei mascherava, vergognandosene. Non è facile essere figlia di eroi, di una famiglia di eroi, visto che in casa di Janet Nathan e Pellegrino Rosselli, nel 1872 morì Giuseppe Mazzini sotto le mentite spoglie di Mr Brown.
Il sentimento di inadeguatezza è evidente in particolare nella poesia Quale azione scegliere, prevedere, ereditare?, in cui è tutta dispiegata la distanza tra scrittura e vita, tra racconto e azione, rispetto all'urgenza della contestazione studentesca e operaia. Ma il fantasma del padre, è stato detto martedì, respira faticosamente anche in molte poesie d'amore: esso è l'assente e l'interlocutore, nel contempo, quel tu, del quale ella stessa dichiarava di volersi liberare in una vecchia intervista rilasciata a Renato Minore, che si può leggere qui: «Tendo all’eliminazione dell’io. L’io non è più al centro espressivo, va messo in ombra o da parte. Credo che solo così si raggiungono risposte poetiche e morali valide, valori utili anche alla società. Ma bisogna evitare il tran-tran montaliano: non parlare né dell’io né del tu».
Insomma questa singolarità lacerata, testimone ed emblema dei mali novecenteschi, che finisce suicida (l'annullamento dell'io non può essere praticato in altro modo, evidentemente), è impossibile circoscriverla in via definitiva, così che i conti tornino; piuttosto va attraversata e riattraversata con pazienza, ripensata non solo a cominciare dal suo breve saggio Spazi metrici, nel quale lei stessa cerca la prigione capace di contenerla e 'misurarla' (laddove la sua riflessione tiene stretta poesia e musica nel laccio delle relazioni quantitative tra forze misurabili), bensì occorre partire dall'inspiegabile che è la vita stessa, di ciascuno di noi, e della sua, così tenera e feroce, così educata da volersi regina della maleducazione, così schifata dell'Italia repubblicana da definirla "paese barbaro", ma anche innamorata delle grandi figure che, in questo paese barbaro, s'impegnarono per cambiarlo, come per esempio Rocco Scotellaro, figura centrale dell'impegno e della poesia postbellica, da rileggere senz'altro.
Ciao e grazie per l'occasione che mi hai dato.
da Documento
proprio prima di dover partire scrissi
perciò voltando il dorso alla promessa
cose molto belle che solo tu con la
tua faccia infantile da ragazzo costretto
ad esser fiero puoi indicarmi.
Sì, scrissi finalmente cose belle, tutte
per te - non v'era pubblico più disattento.
**
Sei nel mio petto, ma poi ti ritrovo,
ma poi ti perdo, ma poi sei lì, e non
vuoi addomesticare il mio sangue che
non ha altra urgenza che di chinarsi
sul tuo tutto indifferente corpo che
annega mentre m'infilo nel letto.
Sei nel mio petto o là ti ritrovo quando
non vedo nel campo o nella miniera altro
che sigarette mezze spente che rinunciano
al significare.
Significando in questo accoppiarsi del
tutto immaginario la tua unione brancolante
in un sospiro di sollievo, che nel mio
petto brilli avventuroso, trovai una
sorta di pace mal costruita mentre battezzavano
le pecore nell'ovile.
**
Quale azione scegliere, prevedere, ereditare?
Un pezzo di pane a cane senza museruola
è meglio che questo scrivere in bianchi
versi di getti lacrimogeni, a branchi
di gente tutta senza importanza o museruola
che scrive vincendo e perdendo tutte
le cause: mentre fuori il tempo gode
e esplode, senza la tua intima perplessità
intimità di cose andate e perdute mentre
tutt'occupata a scrivere versi bianchi
andavi leggendo quel che non si potè
fare.
**
La tua buia fronte
fuoco di erbe e di capitali,
danze di bolle di sapone
entrare nella cucina e non vedere più la propria moglie
o invece disertare il corso di guida
coltivare le piante e maledire le stelle
e in una tragedia ritrovarsi, e in
un verso biasimarsi
dedicati purtroppo ad una volontà di
vivere che rasenta il caos
e in un mare di sangue ritrovarsi.
Brusco mutamento di rotta
una causa che ha tutta l'aria di
voler travolgere anche noi
(parola che non smuove altro che aria
infetta).
Accettiamo di noi l'inconscia libertà
scorpacciata
d'infelici nodi nella sua gola arsa
vittoriosa sembra giocare con l'azzardo
che infine si presenta denudato
presentiamoci vittoriosi e denunciatori
di una realtà se è questa quella
per cui non combattiamo
il giorno
che non ci fu dato altro.
Vinse il migliore nei peggiori dei modi
io ero in cantina a lavare i panni
sporchi tuoi.
**
E una soneria costante; un micidiale compromettersi
una didascalia infruttuosa, e un vento di traverso
mentre battendo le ciglia sentenziavo una
saggezza imbrogliata.
Conto di farla finita con le forme, i loro
bisbigliamenti, i loro contenuti contenenti
tutta la urgente scatola della mia anima la
quale indifferente al problema farebbe meglio
a contenersi. Giocattoli sono le strade e
infermiere sono le abitudini distrutte
da un malessere generale.
La gola nella montagna si offrì pulita al
mio desiderio di continuare la menzogna indecifrabile
come le sigarette che fumo.
**
Lo sdrucciolo cuore che in me è ribelle
quasi sempre in me preferirebbe
una più saggia angoscia
l'animo è davvero poca cosa
è davvero
infernale così come tu dici.
Ma credevo nel soldo e nella miseria
assieme assetati di vendetta: o credevo
nel lento pellegrinaggio ad una fonte
dedicata ad un pubblico e anche privatissimo
dibattito, che essa ingigantisce
così ingegnosa.
Nessuna fede ha mai mosso le montagne
tu muovi le montagne in me, tu che sei
compagno di un momento e senza amore
con quel tuo chiarore di corta vita
l'estate stessa spiovente
nel suo abracadabra di giovinezza irresponsabile
ricevo dalle tue abbondanti e magrissime
braccia.
**
C'è come un dolore nella stanza, ed
è superato in parte: ma vince il peso
degli oggetti, il loro significare
peso e perdita.
C'è come un rosso nell'albero, ma è
l'arancione della base della lampada
comprata in luoghi che non voglio ricordare
perché anch'essi pesano.
Come nulla posso sapere della tua fame
precise nel volere
sono le stilizzate fontane
può ben situarsi un rovescio d'un destino
di uomini separati per obliquo rumore.
Etichette:
lettere agli amici,
poesia italiana
giovedì 2 dicembre 2010
Ercolani legge Chiara Daino
Uno spasimo della scrittura
Leggiamo, in una delle pagine centrali del libro di Chiara Daino, Virus 71, questa frase, stagliata in alto nella pagina: “La vita è un pendolo che oscilla tra massacro e meraviglia”. Daino ci offre, con questo aforisma, una chiave soggettiva di lettura che fa, della dance macabre del suo libro, di questa Spoon River reale di maschi sterminati, un atroce “spasimo” della scrittura. La poesia di Chiara è spasimo e spasmo, il suo linguaggio è spinoso e aggressivo, come la voce dark di Diamande Galas, orientato e disorientato da un continuo martellare ritmico, da un’ostinata tensione barocca della/nella parola. Una poesia scandalosa non tanto per i contenuti erotici esibiti, quasi a scherzo e parodia dell’eros, quanto per la sessualità selvaggia e percussiva della parola stessa. La sua lingua poetica assale con unghiate improvvise, con una vis comica che scardina certezze e canoni. L’uso ricorrente del corsivo, l’iperbole ostentata, la transe radicale del dettato, gli inserti in prosa tesi fino al parossismo, formano una poesia senza pause, acustica, agitata, guerriera, antilirica, che rifiuta le anestetiche bellezze formali e i deboli biografismi quotidiani ma esige la maniacale forsennatezza della sua maschera. In questa violenza di maschera è il suo “essere scrittura”. Anche se, in questo libro, domina la volontà demonica di dileggiare il “canzoniere” amoroso con un capovolgimento carnascialesco e parodico.
La pagina di Chiara non è mai pagina bianca dove le parole si depositano come tracce rasserenate di un’emozione ma foglio da cui trapela la potenza dell’emozione con la sua voce guerriera, infetta, blasfema, stregante, antilirica e assetata d’estasi, il suo rancore anti-mondo, da invasata.
Quanti volumi nella mia vita: pieni vuoti persi vinsi
quanti ricoveri: ricetti e rigetti, vitto e sesso, flebo e gesso
quanti medici quanti musici quanti maschi mediocri
quanti ricordi resi al rum quanti casi clinici collezioni?
corpi contusi quanti lividi ematomi emocromi quanti
vizi quanti analisti arresi quanti organi quanti orgasmi?
Chiara scrive, in una recente intervista a Davide Nota per il portale online “La Gru”:
«Una retta è “parallela” solo in relazione ad un’altra retta. Tanto per incominciare. Si aggiunga che due rette parallele non si incontrano se ragionate nell’ottica della geometria Euclidea, geometria che – spiace comunicare anche questo – non è la sola geometria possibile [ricordare per credere – l'assioma di Riemann: “due rette qualsiasi di un piano hanno sempre almeno un punto in comune”. Per la serie: anche le rette parallele si incontrano, nel prima nel poi. Che sia in un punto o in un postribolo, per bastonarsi o per bere del whisky, poco importa. Le geometrie non euclidee esistono».
Queste affermazioni di poetica ribadiscono che l’armonia è solo un sogno antico e perverso: è inutile produrre sogni deboli, è necessaria un’utopia percussiva, potente. Daino usa la lingua italiana sfruttandone tutte le risorse retoriche e ritmiche, ostile a ogni piattezza espressiva. Spesso ostenta un linguaggio aulico e violento, come liquefatto in brevi colate laviche, sapendo che “La scrittura è fare festa con i fantasmi, perché la scrittura salva e condanna”. Chiara, in fondo, “trama” se stessa:
penelope che mi tramo ricami migliori mi devasto la notte nel tempo disfare bene l’ennesimo epico coccio di carne che replico cronici massacri di maschie miserie riferire cronache di coltelli pugnali ché poi lo sai: l’eternità non si ferma su di noi
Non ci sono tele da fare e da disfare. La tela è Daino stessa, la sua febbre metrica, il suo ardore scritturale incontenibile, che la rende, nel panorama astenico della poesia italiana, una creatura anomala. Ogni sua scrittura è un amalgama violento, un nodo inestricabile. Ogni scrittura autentica è tossica, fino ad essere letale. Non è coperta che salva o protegge, come si illudono certi poeti fiduciosi e ipocriti, ma un panno strappato con cui, al limite, coprirsi le ossa o esibirle in atto di sfida come ultimo insulto da gettare al lettore-passante dalla propria cripta-antro. La migliore prospettiva da cui vedere la propria vita è, parafrasando Ernst Meister, la bara in cui saremo sotterrati.
Il libro si chiama Virus 71 perché – come spiega l’autrice – più che un sorriso è una smorfia [napoletana! E 71 è l'Ommo 'e Merda!.].
Ogni poesia della Daino è un’epigrafe ingiuriosa, una “canzone disperata”. Proprio leggendo questi versi mi vengono in mente le rime del poeta Simone Serdini, detto il Saviozzo. Nasce a Siena nel 1360. Bandìto dalla sua città nel 1389, scrive poesie che chiama disperate, bibliche invettive contro l'insensatezza del cosmo e degli uomini. Muore nel 1420 suicida, in carcere, a Toscanella. Nelle cuciture del manto che rivestiva il cadavere furono trovati questi versi:
«Maledetta la luce e lo splendore
che prima mai s'aggiunse agli occhi miei
e chi ne fu l'autore
co' denti'l teness'io come vorrei!»
Scrive Chiara:
«Cartolina da Genova - dopo anni – dieci – dita sulla tua faccia fantoccio
stringo falangi e schiaccio e spiumaccio dal tuo cranio rotto solo piuma
e gomma bianca lacera ancor la tua testa vuota e brucia ora si vendica»
«La scrittura di Chiara Daino, oltre i limiti della mera comunicazione, - scrive Mirko Servetti alla prefazione dell’inedito non-romanzo della Daino Noi siamo soli - sembra smarrire (su piani di realtà) il proprio destino. È come un sussulto all’interno del moto perpetuo innescato in un movimento centrifugo di perdita, accelerato, inesorabile, che si conclude poi con il tracollo definitivo. È il disastro della scrittura. Ma, al tempo stesso, la sua più viscerale emancipazione». Servetti centra il discorso musicale che sottende la poesia di Daino: un moto perpetuo, una parola che si avvita su di sé, si autotrivella, tende a implodere esplodendo del suo stesso furore.
Un punto, un piccolo piccolo punto,
cerchi il motivo di vanto
la giovane che più giovane [ti senti?]
ti puoi illudere…
mi carico sulla pelle i tuoi anni
sono vecchia per i tuoi trucchi
canta canta forte tu canta pure
ho smesso da tempo di ascoltare
la campana rotta, la cassa capace
non cessa, ti ricorda a tutte le ore
che ci vuole classe – per morire
Ci vuole classe anche per citare Patrizia Vicinelli (perché non si può perché non si deve perché / io vi amo vi amo maledettamente tutti / e mi faccio schifo per questo desiderio d’amore / inappagato) e Emile Cioran (Talvolta si vorrebbe essere cannibali non tanto per il piacere di divorare il tale o il talaltro quanto per quello di vomitarlo). Il leitmotiv di questo libro-pamphlet è una transe da “taranta” che utilizza il motivo del maschio da annientare come occasione del linguaggio di trasformarsi in bollettino bellico, sberleffo marziale, lotta inesausta contro i luoghi comuni
Daino scrive ancora, nella sua intervista a Davide Nota:
Ogni lotta è «lotta di confine», dal singolo al sistema, dal morale al materico: è μέθεξις del margine. […] Il corpo non è contenitore inerme di un contenuto [variabile e variato da soggetto a soggetto], il corpo è lo strumento percettivo primo: ci presentiamo al mondo e il mondo si presenta a noi – nell’accidente/incidente di corpi. Il corpo ci parla e il corpo parla per noi [al di là della fisiognomica, della genetica e di tutta la programmazione neurolinguistica, tutti abbiamo e siamo – anche – la nostra “storia clinica”]. Il corpo ci condiziona e – per quanto possiamo cercare di condizionarlo/cambiarlo/cancellarlo – il corpo pesa, influenza la nostra esistenza. Per quanto la voce possa trascendere o cercare di trascendere la carne: è sempre [e da sempre] una lotta di forze “uguali e contrarie”. La voce di Leopardi sarebbe stata la stessa senza il corpo di Giacomo? Quali Metamorfosi Kafkiane senza le patologie di Franz? E Saffo? E l’elenco tende all’infinito…
Il dramma è il dramma della meccanica dei rapporti. Di tutti i rapporti: con il proprio sé e con l’altro da sé. Dramma della meccanica di azione e reazione, percezione e presa di posizione. La «desertificazione definitiva della Carne» che Ottonieri rileva in Virus 71 – significa proprio il vuoto, l’assenza di quella sintesi che l’umano può e deve: cercare. Conoscere il mondo anche attraverso il corpo necessita che il mondo intenda conoscere – anche – l’oltrecorpo. E quando e quante volte accade? Quale oltrecorpo possibile se i corpi stessi non sono più rispettati, ma solo – usati e abusati [e da noi stessi e dall’altro]?
In questo oltrecorpo di cui parla Chiara c’è un protagonista assoluto, un’armatura-corazza che ricorda la celata di Don Quijote, ben sigillato nella lettura dei suoi libri-incantesimi con cui reinterpreterà la realtà assediandola, popolandola dei deliri delle parole lette, parole incandescenti, più vive del reale, parole di libri che si sono scritti da soli:
«E avanzo con un piccolo scudo per sopportare il peso: una pagina che è coperta, è sacra, è calda. Una pagina serra. Una pagina resuscita. La pagina è sorella, è stirpe simile, perché è una pagina sola. E non è solo una pagina: è la sola che mi suturi. E se perdo il filo mi basta cercare: è lì, placido e cullato nella nota. «Io» è chi cade ai piedi della pagina e insegue la linea: ne basta una – e mi prende la mano, mi prende per mano. «Io» è chi è sempre da sola, ma più sicura – se scrivo. E chiudo a chiave: lo scrigno e la gioia di ragno.
Di foglio in foglio, hanno dato ogni spartito: organi e collane. Libri che si sono scritti da soli. E gli autori? Si sentono meno soli: succinti [sugli scaffali], sorretti [sotto i banchi di scuola], scanditi [in balli di braccia e bignami], … Serafici e serafini sostano sulla scrivania, nelle teche si tengono saldi, nei tuoi palmi si aprono a corolla.
Ora siamo soli: tu mi leggi, io ti scrivo [sempre, anche se non mi rispondi]. Ti dedico tutte le mie parole: sai, io ho solo loro…».
Le citazioni sono tratte da:
Intervista di Davide Nota a Chiara Daino: Born to Lose, Live to Win, in «La Gru, Portale e di poesia e realtà», 7, 2010.
Siamo soli [morirò a Parigi], (inedito, 2010).
Virus 71 (Cagliari, Aisara, 2010).
Su Daino qui in Blanc
[G.T.]
Aveva più anima il mio cibo di bambina
ora la vita clessidra muove verso il basso
e chi curiosa quella cosa che chiami cielo?
quel prendersi per mano e lasciarsi – prendere
la mano a mano: l’ottava più in alto la mano
ti prende la mano perdi di proposito l’ultima
mano persa sul tavolo verde su nero: il tasto
bianco il tono basso nel mezzo calice è cavo
l’arte di perdere – e la tecnica di togliere
l’atleta dell’abbandono si allena: a digiuni, e deserti
ometto come ostacolo come orpello barocco
come bronchi neri, i tuoi baci di catrame:
.................................................quanto fumi?
figaro di forbice fa fette di fiabe di fiati – si tronca
un cuore cinico
[dimentica]
[S.D.]
Più pettino più platino parole,
tanto ti tenebro [tenie taciute!]
quando sarà davvero divertente
il dondolo di carni, quel secondo
di piacere con misto di tortura:
tutte le bugie alla terza moglie,
come quell’allacrima coccodrilla
per tua figlia! forse: figlia non sono?
nata, il cinque di Marzo!, per dire
Il massacro! Ti dico: la Funzione
di quell’altare – che mi sacrifico
invano: non posso salvare tutti!
né i natali, non i miei genitori!
Ché non salvo non spezzo matrimoni!
non si salva, non si spezza! – da soli
siamo soli! solo noi: gli artefici
dei nostri soluti dei nostri squarci!
quel tornado non porta il mio nome!
è tutto tuo quest’Impero Cannibale,
non mi aspettare al freddo: congela!
tutto è morto e come: ti sgozzo,
senza toccarti! così: ti barchetto
il mio sorriso, il ghigno il migliore
Da grande volevo fare l’adulta…
Tu sei vecchio per fare il bambino!
[E.N.]
un punto, un piccolo piccolo punto.
cerchi il motivo di vanto
la giovane che più giovane [ti senti?]
ti puoi illudere…
mi carico sulla pelle i tuoi anni
sono vecchia per i tuoi trucchi
canta canta forte tu canta pure
ho smesso da tempo di ascoltare
la campana rotta, la cassa capace
non cessa, ti ricorda a tutte le ore
che ci vuole classe – per morire.
Iscriviti a:
Post (Atom)