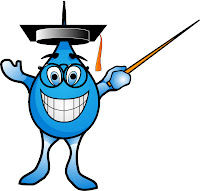Terzo incontro con la poesia albanese (a Cura di Anila Resuli)
Gëzim Hajdari è nato nel 1957 a Lushnje (Albania), si è laureato in Lettere Albanesi a Elbasan e in Lettere Moderne alla Sapienza di Roma. Nel 1990, dopo ben cinque anni di censura, pubblica la sua prima raccolta di poesie dal titolo Antologia della pioggia, edita dalla casa editrice N. Frasheri, con sede a Tirana. Anche il suo secondo libro Il diario del bosco subisce la stessa sorte da parte dei “censori”, ma questa volta non verrà mai pubblicato. Nel 1991 fonda con altri intellettuali il giornale “Il momento della parola” di cui diventa vice direttore. Nello stesso tempo collabora al giornale nazionale “Republika” e insegna letteratura nel liceo scientifico della sua città. Nel 1992 è costretto a lasciare il proprio paese. Da quell’anno vive come esule in Italia, nella città di Frosinone. Attualmente è considerato tra i migliori poeti viventi. Ha vinto diversi premi di poesia, tra cui il prestigioso “Premio Montale” per la poesia inedita. Le sue poesie sono tradotte in greco e in inglese. Hajdari scrive sia in albanese che in italiano, rinnovando un’antica tradizione di poeti (da Seneca fino a Keats, Nabokov, Yeats, Celan) che hanno scritto nella lingua del paese ospitante. Temi ricorrenti nella sua poetica sono la solitudine (condizione esistenziale quasi catartica), il viaggio (come esule, ma anche come essere umano) ed elementi naturali come la pietra, la terra, il cielo.
Tra le opere, oltre quella citata, ricordiamo: Muzungu. Diario in nero, Poema dell'esilio-Poema e mërgimit, Spine nere, Stigmate - Vrage
Da Stigmate/Vragë
*
Quanto siamo poveri
io in Italia vivo alla giornata
tu in Lushnje non riesci a bere un caffè nero
la nostra colpa: amiamo la terra
la nostra condanna: vivere soli divisi dall'acqua buia
ritornerò in autunno come Costantino
mentre sulle colline natali tu già hai raccolto l'origano
da portare nella mia stanza ancora sgombra
ora vivo al posto di me stesso
lontano da un paese che divora i propri figli
*
Ho girato su e giù per le strade di Roma
per vendere il mio Corpo Presente
è l'ultimo giorno dell'anno santo
come posso giungere a festeggiare con te dopo otto inverni
in Occidente
il viaggio costa venti volte il prezzo del mio libro di poesie
e nei tuoi occhi la mia assenza diventa più profonda
sulle tue labbra secche il mio nome è pronunciato più spesso
alti sono i muri d'acqua che ci dividono
e sotto le loro ombre cresce spaventata la nostra vita
*
I tuoi poeti cantano ai tiranni
perché i tiranni li affascinano
non sono uomini liberi i tuoi poeti
i tuoi poeti non vogliono morire da poeti
con umiltà di cane accanto ai propri tiranni
cercano di dividere il grande Vuoto con confini
e brindare sotto le ombre delle bandiere
i tuoi poeti non hanno sete d’amore
ma d’acquavite
chiusi nei piccoli cieli
lasciano che si laceri la Parola
*
Fiume tu devi raccontare che sono stato anch’io come
il grano del campo la rosa canina del bosco oscuro
ho vissuto come te sempre con addosso la roba umida
affamato di esistenza incantato dal girasole
in un secolo in cui la gente
camminava guardando per terra
ho trascorso da solo sere di pioggia tagliente
dietro vetri bagnati
con il pensiero di creare con il coltello di ieri
un’altra patria di pietra
nel mio corpo tremante dell’est
*
E’ scritto che non avrò mai un punto fermo
né una porta da varcare sera e mattina
né una soglia dove poggiarmi con la mia follia
quanto ho sognato che qualcuno mi svegliasse di buon’ora
mi accompagnasse con lo sguardo alla partenza
e mi aspettasse con impazienza al rientro dall’immenso
mai un dolce sussurro all’orecchio
da piccolo mio padre mi mordeva la testa
quando perdevo una pecora al pascolo
dormivo nel pagliaio la notte
chi veglierà su di me un giorno in mezzo
alla stanza sgombra
chi mi butterà un pugno di terra fresca
chi scriverà sulla mia pietra grezza due parole semplici
chi dirà per me una preghiera dopo l’addio
con me sempre in sibilo del vento dei viaggi
e l’insicurezza dell’indomani
perché sono nato? perché sono vissuto? perché ho cantato?
i miei laggiù se ne fregano dei miei libri
da me aspettano solo belle macchine e milioni!
brutta sorte la mia, terribile la pena:
fuori da te e dalla tua lingua
La poesia di Gëzim Hajdari nasce come poesia dell’esilio: tutta la condizione umana ruota intorno alle radici in un miscuglio forte di metafore e simboli. Non vi è felicità o consolazione in questa condizione, ma rabbia fitta e densa che parte già dalla terra natale con la persecuzione del poeta stesso come Intellettuale nella propria terra, e Intellettuale in esilio, come portare della cruda verità sulla “condizione” dei poeti/intellettuali in patria. La poesia quindi denuncia un’insoddisfazione, un peso gravoso che accompagna il poeta durante ogni pensiero della giornata, sulla vita, sulle cose e sulle persone che frequenta ogni giorno. I volti quindi diventano delle richieste di risposte, delle domande continue su quello che l’esilio lo portò a lasciare. Anche l’amata è vista come il confine tra patria ed esilio: la sorte è una pena, un’attesa continua di qualcosa che mai verrà restituito. Come poeta si sente di denunciare il vero, come uomo si lascia sgretolare i nervi, i sentimenti e il cuore in un abisso di “non-speranza”. Nemmeno l’amore quindi può consolare. Persino la morte sembra un ulteriore esilio dove nessuno sarà presente, dove la propria gente nemmeno riconoscerà il poeta, l’uomo stesso. Naturale quindi il porsi la domanda “perché sono nato?”: il negare l’esistenza stessa è quindi meglio che vivere senza esistere nel cuore di chi l’ha visto crescere, la propria terra.